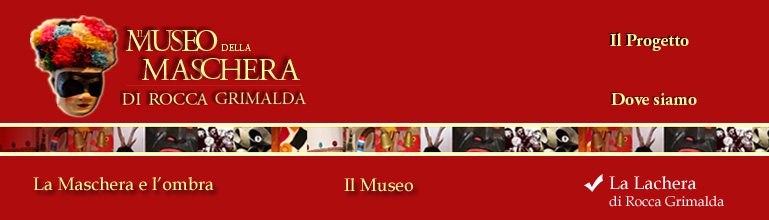
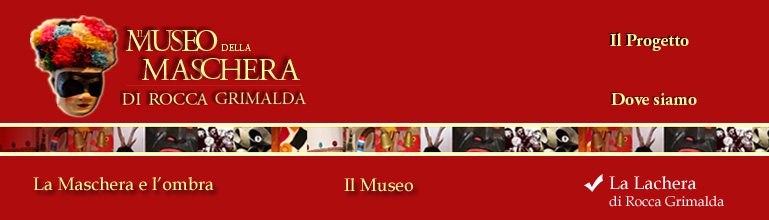
| Home/La Lachera/I personaggi |Descrizione e morfologia della Lachera|La Lachera nel tempo | |||
 |
|||
Il Corteo e le danze Nel
contesto originario di Rocca Grimalda, la Lachera consiste in un corteo
mascherato che al seguito di una coppia di Sposi percorre le vie del paese
secondo tappe prestabilite dalla tradizione. |
||
I brani video "La Giga" e "il Calisun" sono tratti dal film etnografico: Piercarlo Grimaldi (a cura di) , La Lachera, regia di Pino Polacchi, CLAU, Torino, 1998. Il brano video "La Lachera" è tratto dal reportage etnografico di Luca Percivalle, Rocca Grimalda 2008.
|
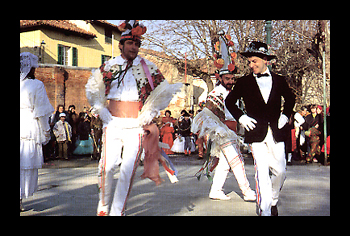 |
|
||||
 |
|
||||
 |
|
Morfologia Così
come appare dalla documentazione e dalla rigorosa ricostruzione di Franco
Castelli, un’interpretazione corrente vede nella Lachera la rievocazione
di una presunta rivolta popolare che sarebbe avvenuta nel XIII secolo
contro l’esercizio dello jus primae noctis da parte del
feudatario locale Isnardo Malaspina. Tuttavia, tenendo conto della straordinaria
densità folclorico-carnevalesca dell’apparato simbolico,
la festa sembrerebbe piuttosto risentire della avvenuta storicizzazione
in epoca moderna di un rito più arcaico, secondo una riconversione
in senso politico (la rivolta popolare contro un potere crudele e illegittimo)
che ha del resto interessato un gran numero di altre feste tradizionali.
In proposito Castelli cita il Toschi, che mette in luce il depotenziamento
che tali modificazioni hanno finito per comportare nei confronti degli
originari temi “nuziale” e “agonistico”, che andrebbero
rispettivamente ricondotti alla propiziazione della fecondità e
allo scontro tra vita e morte, inverno e primavera, sterilità e
fecondità.
Lo
schema redatto da Castelli ne rappresenta coerentemente personaggi, attributi
e relative funzioni: la coppia di sposi, circondata da personaggi scherzosi
e festanti, sempre connotati da tratti individuanti la fertilità,
vale a dire – nelle culture tradizionali – lo scopo primario
se non addirittura quasi esclusivo del matrimonio stesso. Data l’evidenza
del tema “nuziale”, ancora ricorrendo alla classificazione
del Toschi, risulta però meno evidente il tema “agonistico”,
che tuttavia sembrerebbe trapelare da una certa aggressività dei
“trapulin”, figure chiaramente derivate da maschere zannesche
della Commedia dell’Arte. Questi ultimi infatti prendono posto agli
angoli del virtuale “quadrato magico” in cui sono iscritti
gli Sposi e la loro “corte”, facendo sistematicamente schioccare
le fruste di cui sono armati, quasi a preservare lo spazio del corteo
mascherato da ogni intrusione. Ma quale?
O forse, se proviamo a seguire
un’ipotesi comparatistica, l’intruso da cui guardarsi potrebbe
essere colui che nei riti del ciclo della vita (charivaris compresi)
rappresenta tradizionalmente ciò che nei carnevali è l’inverno
nei confronti della primavera, vale a dire la figura del “vecchio”,
che ancora di recente Jean-Dominique Lajoux ha direttamente riscontrato
nel folclore slavo, riconoscendone l’essenziale centralità
nei “finti matrimoni”: «Le Vieux est un personnage
clef des mascarades nuptiales. Il est décrépi, bossu, boiteux,
fourbu de rhumatismes, mais tout claudiquant, il suit de prés la
mariée tout au long du cortège [...].Le Vieux, de temps
à autre, invective et menace gestuellement le couple ou le marié».
Gesti pateticamente aggressivi come si vede, a rappresentare la comica
e rabbiosa ostilità di una vecchiaia che, sentendosi scavalcata
dalla superiore energia sessuale della gioventù, non riesce tuttavia
a darsene pace e ad ammetterne l’inevitabilità. E non è
raro, precisa ancora Lajoux, che il vecchio venga schernito e irriso dai
personaggi mascherati, sospinto al di fuori del corteo, o addirittura,
come accade di vedere in Anatolia, aggredito e ucciso ritualmente : «Au
cours d’une querelle avec le Nègre, il succombe
même à l’issue d’un simulacre de combat».
Il “negro”, un pastore con il volto infericamente imbrattato
di pece, è evidentemente del tutto isomorfo, per chiare “somiglianze
di famiglia”, a quei “trapulin” che del resto, nella
popolarissima Commedia dell’Arte, avevano il compito di aiutare
i giovani a convolare a giuste nozze contro le gelosie e le pretese resistenze
dei Vecchi. Comunque sia, va perlomeno segnalato che a partire dall’edizione
del 1998, la già citata figura del “guerriero” è
stata reintrodotta proprio con la funzione di disturbare il corteo nuziale
e che, in singolare analogia con i casi segnalati da Lajoux, alcuni personaggi
(nella fattispecie gli Zuavi) si incaricano di scacciarlo mulinando le
loro spade: il Signore dello Ius primae noctis, forse, ma chi,
originariamente? Bibliografia Martinotti,
M.,(scheda musicologica) in Castelli,
F., La danza contro il tiranno : leggenda, storia e memoria della
Lachera di Rocca Grimalda, Rocca Grimalda, 1995, pp.
98-102.
di Margherita
Amateis
|
![]()